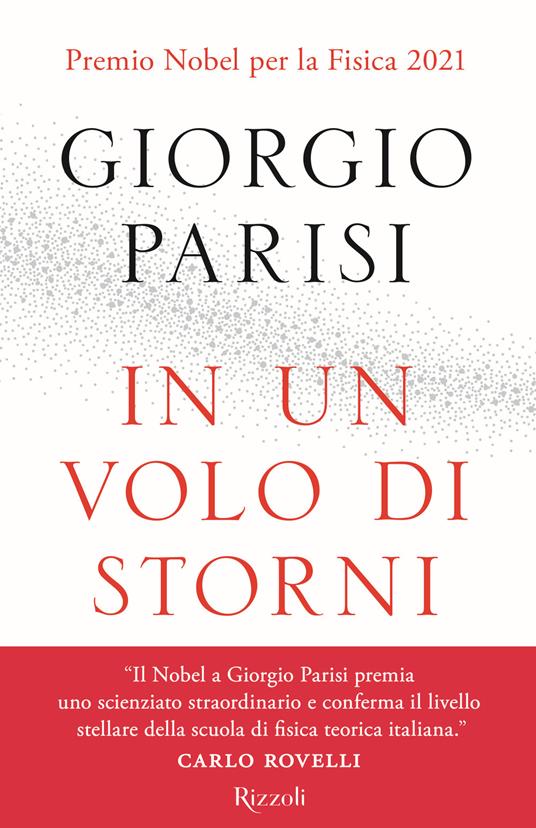«In un volo di storni» è stato pubblicato da Rizzoli nel 2021, per celebrare l’assegnazione del premio Nobel a Giorgio Parisi. L’autore non ha certo bisogno di presentazione, ma non si può non ricordare il suo impegno come ricercatore presso i Laboratori nazionali di Frascati a inizio carriera, il suo lavoro come docente universitario prima di Fisica teorica e poi di Teorie quantistiche, e il premio Nobel dell’ottobre del 2021 «per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria». Giorgio Parisi ha lavorato per anni a questo libro e le interviste che gli aveva fatto la saggista Anna Parisi sono diventate le tracce dei capitoli.
Il primo capitolo è dedicato al progetto che gli è valso il Nobel e, fin da subito, Parisi mette in evidenza le domande dalle quali è nato il percorso, oltre alle difficoltà che si sono palesate e che hanno reso necessario il coinvolgimento di persone esterne all’ambiente della fisica, come due ornitologi e un economista. Nel secondo capitolo, l’autore descrive la fisica di cinquant’anni fa: parte dalle motivazioni della scelta che l’hanno portato a studiare questa disciplina, parla di comunicazione scientifica e collaborazioni a distanza, e confronta la tecnologia dell’epoca con quella attuale. Rivendendo il percorso, Parisi dice che «le idee spesso sono come un boomerang: partono in una direzione ma poi vanno a finire altrove» e «le applicazioni possono apparire in campi assolutamente imprevisti», tanto che anche il risultato del premio Nobel, la teoria dei vetri di spin, è nato dallo studio di un problema di particelle elementari. Il terzo e il quarto capitolo sono i più tecnici del libro e richiedono una certa dose di impegno per seguirne lo sviluppo, anche se non mancano immagini esplicative: il primo è dedicato alle transizioni di fase, ovvero ai fenomeni collettivi, mentre nel secondo l’autore descrive la «matematica strana» che si è resa necessaria per i suoi studi e che, allargando la prospettiva, si è rivelata uno strumento «concettuale molto potente e utile per risolvere una vasta gamma di problemi in apparenza anche disconnessi tra loro». Arrivare a una comprensione concreta dei processi reali non è certo semplice, anche se, «una volta che il lavoro sarà finito, allora sembrerà semplice. Quando si studia sui libri una teoria di fisica o un teorema matematico sembra tutto così chiaro. Scompare completamente la quantità di lavoro complicato che è stata necessaria per ottenere il risultato.»
Nel quinto capitolo, Parisi parla delle metafore, di come possano essere utili o fuorvianti, di come possano fare da ponte tra due saperi diversi, ma al tempo stesso creare malintesi, e di come i modelli fisici stessi possano essere considerati metafore che si adattano ad ambiti diversi tra loro. È proprio parlando attraverso metafore che Parisi scrive che «il fisico a volte usa la matematica in maniera sgrammaticata, ma […] il non seguire tutte le regole della grammatica è una licenza che si concede ai poeti.» Il sesto capitolo celebra la creatività: è uno dei capitoli più ricchi, perché il lettore non può che restare affascinato dal modo di lavorare della mente di un fisico. Con il penultimo capitolo, intitolato «Il senso della scienza», Parisi ricorda che la scienza è cultura ed esprime la necessità di trasmetterla alle future generazioni. Il capitolo di chiusura è dedicato a un aneddoto, con il quale l’autore ricorda di essersi giocato, per un errore, la possibilità di vincere il premio Nobel a 25 anni.
Nel corso del racconto, Giorgio Parisi ricorda che «in fisica e in matematica è impressionante la sproporzione tra lo sforzo per capire una cosa nuova per la prima volta e la semplicità e naturalezza del risultato una volta che i vari passaggi sono stati compiuti». Anche se il processo creativo e i dubbi che hanno portato al risultato, ricorda più volte, sembrano non aver lasciato alcuna traccia, il percorso di scoperta è ricco di errori e fallimenti, come l’esperienza stessa di Giorgio Parisi ci ricorda, pur potendo contare sul sostegno dei maestri, degli allievi e dei colleghi, perché «anche la ricerca è un fenomeno collettivo, un sistema complesso».
Hai domande?
Contatta l'autrice